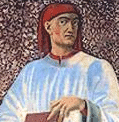BOCCACCIO |
|
|
--------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
IL MONDO DEL DECAMERON
|
|
| Torna a Boccaccio |
|
Il Boccaccio, come si è visto, da giovane fece a Napoli esperienze non solo nel campo commerciale, che poco lo attirava, ma soprattutto nel bel mondo della corte del dotto re Roberto d'Angiò, ove poté soddisfare le sue esigenze intellettuali e le sue giovanili ambizioni artistiche, oltre che appagare la nativa esuberanza d'una cordiale adesione alla vita cortese e gaudente. Ne ricavò un atteggiamento di aristocratico distacco nella comprensione dei veri problemi della realtà sociale e la tendenza al sogno ed al vagheggiamento di riti classici e di nobili ardori. Ma l'approccio con una realtà ben diversa, più cruda e più prosaica, che dovette affrontare dopo il fallimento del padre e il ritorno a Firenze, lo costrinse ad una più realistica visione della vita: l'amore cortese, il sentimento cavalleresco, la soave dolcezza delle Muse antiche divennero tutti cittadini d'un mondo ormai passato e lontano, da conservare come un bene prezioso e incorruttibile, ma non più attuale e soprattutto inadeguato alla soluzione dei reali problemi esistenziali che gli si presentavano. Fu dunque necessitato a guardare il mondo con senso più obiettivo, più realistico, e si accorse che esso andava in direzione opposta a quella che si era immaginata da giovinetto, che esso riponeva le sorti del proprio destino nella ricchezza materiale, nell'appagamento dei bisogni più naturali, nel godimento dei piaceri mondani. In altre parole, che il mondo dei cavalieri aveva ceduto il posto al mondo dei mercanti, che la grazia e la nobiltà dei sentimenti avevano ceduto il passo alla furbizia ed alla malizia, così necessarie al successo economico, alla conquista amorosa. La sua maturità artistica fu il frutto della sintesi di queste due cosi diverse esperienze. Egli sentì di dover narrare la vita cosi com'era, come gli scorreva dinanzi agli occhi, ma anche di dover conservare per sé quell'aristocratico distacco, retaggio dei sogni giovanili, e quel tanto di pudore sufficiente a non farsi coinvolgere nella volgarità della vita reale. La quale, però, era quella vera e che proprio per questo andava cordialmente accettata, non giudicata. E descritta con la simpatia di un animo superiore ma non estraneo alla comune condizione dell'umanità. Per questo il "Decameron" risulta un grande affresco della società italiana, e particolarmente fiorentina, del Trecento. In esso è significativa l'intuizione che l'umanità va sempre più distaccandosi dall' idea dell'aldilà ed e decisamente orientata a valorizzare la vita terrena e l'opera dell'uomo, della quale si rivendica l'autonomia da ogni interferenza di natura celeste. Ne consegue che la qualità umana più rilevante ed esaltata è 1' intelligenza, anche quando si degrada a furbizia, a qualsiasi fine sia essa rivolta, indipendentemente dalla natura morale dei risultati conseguiti, che possono essere nobili o volgari, onesti o disonesti. Nel narrare la trovata di ser Ciappelletto, che da gran manigoldo che era stato per tutta la vita, in punto di morte riesce a convincere il confessore d'essere un santo (e come tale verrà venerato da tutta la cittadinanza), pensando che il Padreterno, dopo i mille e mille affronti subiti da lui, possa bene accettare anche questo, dato che, alla fin fine, esso sarà veramente l'ultimo: nel narrare questa spassosima vicenda il Boccaccio si diverte e si compiace col protagonista, non si scandalizza per niente, perché il mondo va così ed è forse naturale che vada nel senso voluto dai furbi anziché in quello indicato dagli stolti. Quindi c'è poco da scandalizzarsi se, chi ce l'ha, sfrutti la propria intelligenza a scapito degli stupidi, sia se c'è in ballo un profitto economico che se si tratti di conquistare una donna, di spuntarla sulla più accanita difesa della propria castità. E 1' amore è l'altro aspetto dominante della vita dell'uomo, quale che sia la sua natura, platonico e sensuale, rasserenante o sconvolgente, segnato da una tragica fedeltà o da una infedeltà comicamente disgustosa. Questi aspetti naturali dell'esistenza umana vengono dal Boccaccio calati in vicende e personaggi concreti realisticamente descritti con analisi minuziose o semplicemente abbozzati, ma sempre con un eccezionale acume psicologico. La vasta galleria di personaggi del "Decameron" comprende una gran varietà di esemplari umani: il ricco e il povero, il nobile e il plebeo, l'antico "cavaliere" e il moderno "trafficante", il saggio e l'insipiente, il furbo ed il gonzo. Tutti fanno parte del mondo e perciò hanno diritto alla comprensione dell'uomo ed al rispetto dell'artista. |
|||
|